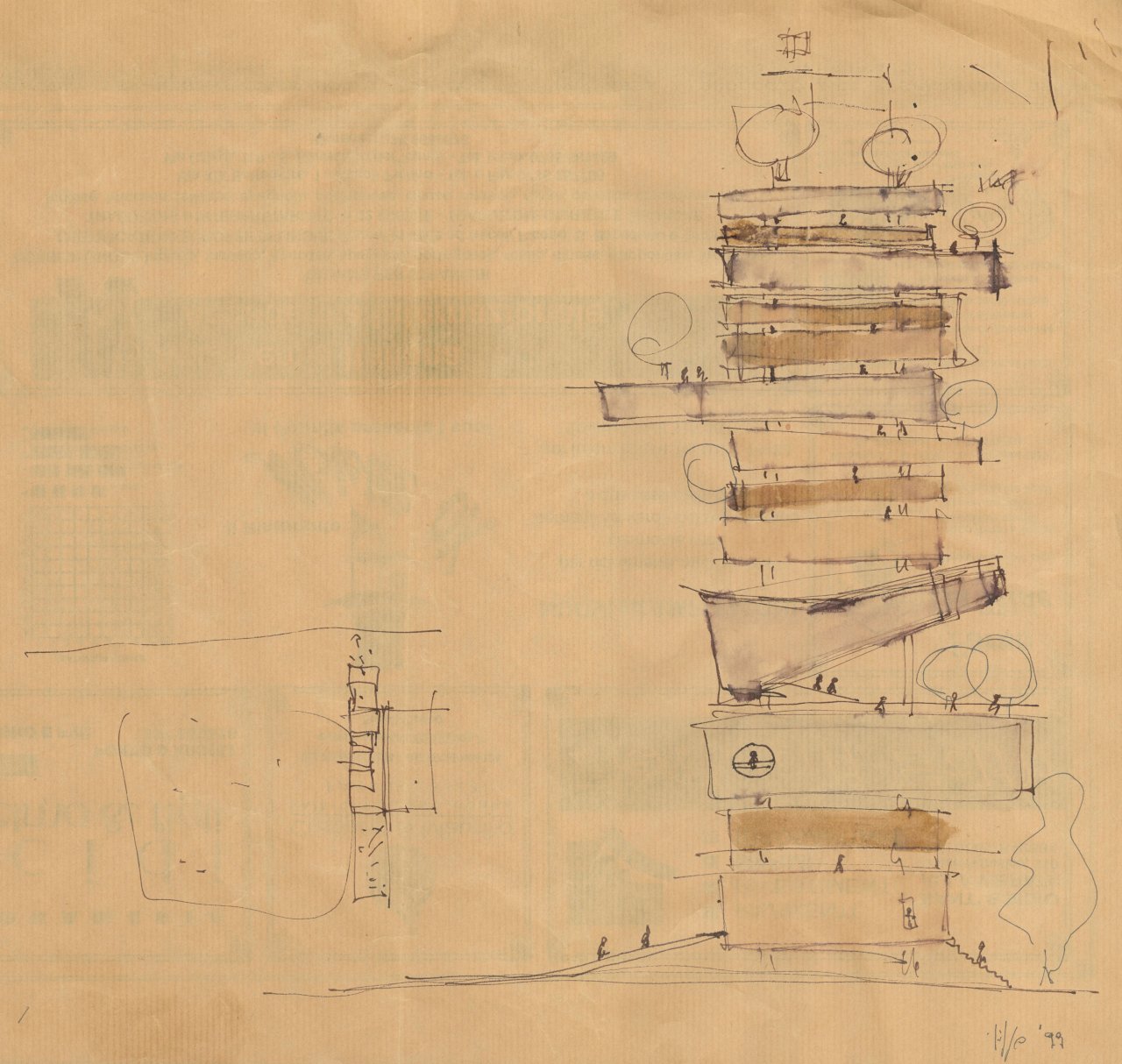A cura di Valeria Tassinari
Ouverture
«Ho un lavoro tridimensionale, base, altezza e tempo. Base per altezza e tanto lavoro artigianale.»1
Suite chimica è il titolo di una nuova mostra, ma anche il titolo di una mostra che c’è già stata, perché il lavoro del suo autore si fonda su pratiche e forme, generate da un’idea fondativa persistente e ritornante, una ricerca che si ripropone costantemente pur non rinunciando ad intonarsi alla specificità di ogni evento espositivo.
La personale site–specific di Roberto Rizzoli per lo spazio Lavì City, infatti, è concepita come un progetto pittorico unitario che, attraverso un’attenta impaginazione in parete di diverse tele libere, coinvolge completamente l’ambiente della galleria, e con questo si misura, fisicamente e percettivamente. La stanza, di dimensioni raccolte, si trasforma in una grande opera corale, strutturata dall’autore declinando il tema della “suite2” musicale in una sequenza di variazioni cromatiche, costruite attraverso una serie di opere pittoriche, nelle quali la ripetizione di composizioni astratte esibisce un raffinato repertorio, i cui preziosi accordi sono attinti da una profonda conoscenza della storia dell’arte. Dalla policromia fino al bianco e nero, la pittura ripete e rilegge gli schemi segreti della pittura stessa, in un lucido processo di riappropriazione della sua bellezza, che si basa su una disciplinata rielaborazione razionale, ancorata al controllo del tempo, dimensione della memoria, ma anche misura dilatata, necessaria per la restituzione “artigianale” della materia e per la comprensione della sua spiritualità.
La tridimensionalità del lavoro – identificata dall’autore nella combinazione delle due misure lineari della superficie dell’opera con la misura psichica del tempo, fondamentale per i processi di concepimento, sedimentazione e produzione – si assesta qui nello spazio, avvolge il vuoto e lo incornicia, occupandone la profondità con una sorta di perentoria delicatezza. Limite e confine, la pittura diventa frontiera permeabile allo sguardo.
Allemanda (lenta)
«Il tempo è una linea orizzontale che unisce le caverne di Altamira a Duchamp e ti lascia la libertà di non scegliere.»
Il lavoro del tempo è uno dei misteri sui quali l’uomo non può fare altro che scendere a compromessi. Diamogli una forma, e sarà una linea; diamogli una direzione, e sarà una freccia; cerchiamogli un senso e, paradossalmente, sarà un pendolo che oscilla nella mente, un gioco di forze che si alternano, sfiorato dal soffio della memoria e dell’oblio. La possibilità di muoversi nella storia dell’arte come se il tempo non fosse misura di una distanza ma segnale di persistenza, incidenza, identificazione, è una certezza che libera dall’obbligo ossessivo della ricerca del nuovo.
Stare sul solco, muoversi come scivolando, il passo che fluisce e torna indietro, un giro sulle punte, girare pagine di libri in direzione opposta alla sequenza grammaticale, capire Rothko in Piero della Francesca, e Giotto nella Metafisica. Intorno all’arte, quello che cambia è la cronaca dei fatti, il tempo è altra cosa.
Suite chimica, dunque, è una mostra di nuove opere pittoriche, ma la metrica della sua identità ritmica esisteva già nei lavori fotografici presentati da Roberto Rizzoli nella sua prima personale, allestita allo Studio G7 di Bologna negli anni Settanta. La struttura delle immagini e il bilanciamento del rapporto luce/ombra erano temi nitidamente definiti negli scatti fotografici di allora, stessa astrazione elusiva, stessa volontà di stare assolutamente dentro all’immagine, senza deragliamenti all’esterno. Cinquant’anni sono così pochi, in fondo, se la misura del tempo parte dalla preistoria. Un giro di stanza, in una piccola camera, da qualche parte che si fa luogo irripetibile.
Corrente (veloce)
«L’artigianato è un valore aggiunto a quello dell’arte.»
La pittura si fa con la pittura, non ci sono altre possibilità. Il colore, l’ombra, la luce, il gesto, il segno, il pieno, il vuoto, la texture fanno la pittura. La figura no, è un’altra cosa, è un racconto che si può fare in tanti modi, anche con la pittura. In questi lavori di Rizzoli la figura non c’entra più. Il controllo del linguaggio qui è una pratica di ripetizione, selezione, revisione, accostamento, estrazione e astrazione. Nelle tele libere la pittura si concentra al centro, un rettangolo impercettibilmente tattile organizza la superficie in vibrazioni cromatiche che attingono agli spartiti timbrici delle tavole del Trecento, o alla gravità tonale di un paesaggio veneto, fino al trasmigrare del bianco nel nero in dialoghi di luce pura. Intorno, sulla tela nuda, tra i pochi segni liberi in cui si concede di sconfinare, Rizzoli appunta riflessioni rapide, guizzanti. Una corrente, un brevissimo evento, come un corteggiamento intorno a un’apparizione.
Sarabanda (lenta)
«La libertà di non scegliere mi permette di decidere come gestire la superficie.»
La superficie è il luogo, per un pittore è lì, o prima di tutto lì, che ci si mette alla prova. Per questo la si sceglie, o la si lavora, costruendola con lenta consapevolezza. Sotto le dorature e le tempere fragranti dei Primitivi pregiotteschi le tavole erano preparate con imprimiture segrete, e più tardi i pittori otturavano la porosità delle tele con tonalità colorate, talvolta cupe, per dar risalto alla pelle traslucida della pittura ad olio. La preparazione delle superfici esisteva come condizione di partenza: non vista, perché obliterata dall’immagine, rimaneva comunque preziosa in quanto azione controllata dalla volontà dell’artista, era preludio intimo, aveva un senso tattile e immateriale. Nella sua pittura, Rizzoli lascia invece uno spazio di affioramento, dichiara apertamente che la preparazione della superficie è parte del processo e, proprio perché il processo stesso è il tema, nel suo svelarsi si completa l’unica forma possibile di racconto. Pittura e basta, su vari livelli.
Giga (veloce)
«Il risultato è un lavoro autobiografico che nel tempo mantiene alcune costanti, l’artigianalità, un rispettoso e appassionato collegamento con tutta l’arte che mi ha preceduto e per tutto ciò che sembra ma non è.»
Sembrare senza essere, grande teatro del mondo. Ripetizione di sogni inutili e per questo sempre attuali. Rizzoli approda all’opera come risultato di una sequenza perfetta di procedure e puntualizzazioni di registri. I passi sono compiuti, ogni nota riverbera, la tela può essere fissata alla parete.
Inchino a occhi aperti. Uscita.
| 1 | Le parti di testo in neretto sono di Roberto Rizzoli. |
| 2 | La Suite (successione) è un genere di componimento musicale che ha trovato struttura stabile in Europa nel periodo barocco. Talvolta introdotta da un’ Ouverture, si struttura tipicamente nell’alternanza di danze lente e veloci, che ripetono in successione una tonalità costante. |